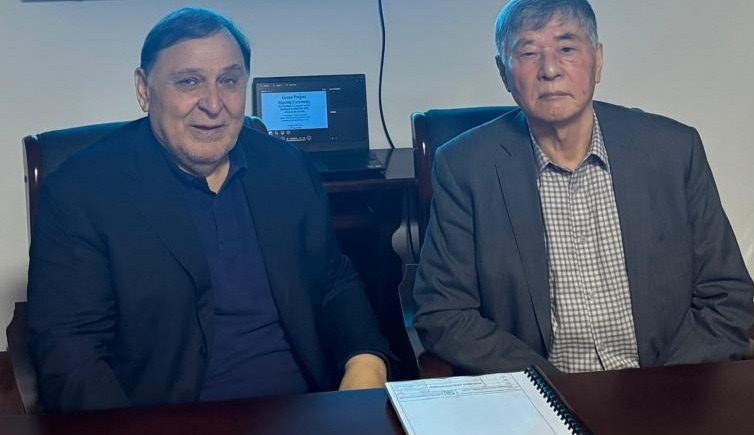Idea Trump: “supermulta” nei porti Usa per chi ha navi costruite in Cina
Ecco perché la misura-boomerang avrà contraccolpi anche su scali come Livorno
LIVORNO. La guerra dei dazi scatenata dal nuovo presidente statunitense Donald Trump riguarda molto da vicino l’export italiano che ha un forte flusso di merci verso gli Usa, in particolare riguarda un porto come quello di Livorno che da almeno due secoli ha una storica vocazione come punto di riferimento per le merci spedite al di là dell’Atlantico nei porti americani. Per dirne una: si pensi alla minaccia americana di istituire un dazio del 200% sui vini italiani e francesi come “bomba atomica” nello scontro con l’Unione Europea che, in risposta all’attacco Usa a suon di dazi, aveva puntato su una stangata del 50% sul whisky statunitense.
Ma in questa guerra commerciale – che sta facendo esplodere la geografia dei flussi commerciali quasi più del Covid e della conflitto armato in Ucraina – c’è anche un altro aspetto che rischia di coinvolgerci: la Casa Bianca sta studiando una mossa, probabilmente un ordine esecutivo, che spara una cannonata contro la cantieristica navale cinese. Detto così, chi se ne infischia. In realtà, no: per colpire il disegno strategico di Pechino il provvedimento al quale si sta lavorando a Washington prende di mira gli armatori che hanno costruito le navi in cantieri cinesi. Dunque, è data per scontata una penalizzazione per le navi costruite in Cina che volessero entrare in porti statunitensi: a quanto pare di capire, non solo se vi arrivano per scaricare merci destinate a entrare in territorio americano ma perfino se utilizzate, nel continuo carico/scarico delle toccate in porti schedulati lungo le grandi direttrici mondiali. Già così riguarderebbe una fetta delle navi che collegano alle coste americane i porti italiani, e nella fattispecie Livorno.
Dietro l’angolo il bazooka contro le navi “cinesi”
C’è però un aspetto ulteriore da mettere nel conto, ed è ancor più devastante degli equilibri della logistica planetaria. Nel dossier dell’ “Office of the United States Trade Representative” (Ustr) che la Gazzetta Marittima ha potuto consultare, figura sotto esame una misura che allarga lo spettro di azione dei dazi a gran parte delle flotte mondiali esistenti. In pratica: non si punisce la singola nave se risulta di fabbricazione cinese ma soprattutto ciascun armatore che abbia fra le proprie navi una quota di navi fatte costruire in Cina, magari in anni lontani, o anche soltanto ne abbia ordinata la prossima realizzazione in uno stabilimento navalmeccanico in una qualche città cinese. Stiamo parlando di cifre nell’ordine del milione di dollari se l’armatore ha fatto costruire in cantieri cinesi più del 75% della flotta, qualcosa meno (750mila dollari) se le portacontainer di fabbricazione cinese sono fra il 50% e il 75% delle proprie navi e via dicendo.

Porto di Livorno: sulla sinistra, l’area dove sorgerà la futura Darsena Europa; sulla destra, la Darsena Toscana; al centro, la quattrocentesca Torre del Marzocco
La traduzione la fa in casa nostra un manager livornese attento a quel che si muove sul fronte americano: è Angelo Roma, vicepresidente dell’Interporto Vespucci di Guasticce. «Uno degli aspetti fondamentali di quanto sta elaborando l’ Ustr, uno degli uffici di diretta collaborazione del presidente Trump, è l’idea di addebitare un milione e mezzo di dollari per scalo negli Stati Uniti per qualsiasi nave portacontainer fabbricata in Cina, e questo al di là di quale sia la proprietà o la bandiera della nave».
Nel mirino chi ha le navi costruite in Cina: quasi tutti
L’Ustr ha avviato una fase di consultazione con gli interlocutori interessati fino al 24 marzo, poi si prenderà qualche settimana per arrivare a definire una propria proposta definitiva da presentare alla firma di Trump. «Bisogna tener conto – dice Roma – che è stato costruito in cantieri cinesi poco meno del 38% delle navi portacontainer attualmente esistenti e in attività. E non è finita: se guardiamo al portafoglio ordini di navi per il trasporto contenitori al momento se ne contano quasi 800, tutte insieme sviluppano una capacità complessiva superiore ai nove milioni di teu. E dove vengono costruite le navi che solcheranno gli oceani in futuro? Per oltre il 70% di esse si tratta di cantieri navali della Cina. Per dirla in altri termini: se puntiamo lo sguardo sui primi dieci cantieri navali in fatto di numero di navi ordinate, ben sette sono all’interno della Cina».
Resta da capire se, essendo gli Usa un mercato di destinazione ancora rilevante, cosa sceglieranno di fare gli operatori: se, prima ipotesi, pagheranno queste “multe” (che a catena si scaricheranno sui consumatori americani) o se, in alternativa, inizieranno a snobbare gli Stati Uniti. Oppure ancora, terza possibilità, se adotteranno il solito vecchio trucco della triangolazione: sostituire con porti canadesi o messicani (o, meglio ancora, latino-americani, forse caraibici) i porti statunitensi per recapitare la merce e poi reinviarla verso gli Usa. Fatto sta che l’effetto di queste sconclusionate misure trumpiste è difficilmente prevedibile: chissà se è solo un agguato mediatico la contestazione – divenuta video ultravisualizzato – del deputato repubblicano Chuck Edwards a Asheville, un paesone tipo Campobasso ma in North Carolina (qui il link al video pubblicato da Corriere.it), proprio per il caos che si sta scatenando senza che cali lo stramaledetto prezzo delle stramaledette uova dell’americano a basso reddito infatuato dal tycoon.
È da rimarcare che, secondo l’analisi di Holland & Knights, un esercito di 2.200 avvocati per uno studio legale al 31° posto nella classifica mondiale, il tentativo di rianimare l’industria a stelle e strisce passa anche attraverso l’imposizione dell’obbligo di affidare l’export Usa a navi battenti bandiera Usa fino a raggiungere una quota del 15% entro sette anni. Ma non si capisce come fa un percentuale a essere un obbligo: a chi tocca e a chi no? O è un “obbligo” ordinatorio ma non perentorio, e dunque poco più di una raccomandazione robusta…
La trattativa con la pistola sul tavolo
In effetti, gli atteggiamenti da gradasso di paese che il presidente Trump sembra voler attuare mirano soprattutto a dettare l’agenda della trattativa, e farlo mettendo la pistola sul tavolo: un po’ Masaniello un po’ cowboy, insomma un modo disinvolto e spaccone per far credere al ceto medio impoverito che lui, Trump, le sta tentando di tutte per fare l’America di nuovo grande e potente spuntando condizioni migliori. Dietro di lui, però, non c’è solo la voglia di fare il bullo che ne ha contraddistinto la presunta ascesa imprenditoriale che è soprattutto la gestione dell’impero ereditato dal padre: Bob Woodward, il principe dei giornalisti investigativi americani, racconta il sistematico rifiuto di pagare con cui il Trump imprenditore rispondeva alle ingiunzioni degli uffici governativi per tasse e multe.

L’interno di una grande fabbrica in abbandono nel Michigan
Ma dietro Trump c’è un problema che è enormemente più grande di Trump: è la disperazione di un apparato industriale statunitense che non ce la fa più a reggere la competizione commerciale con i cinesi e, men che meno, con gli europei. I fronti in cui va alla grande sono i big tech della nuova economia digitale: il regolamento di conti è con l’Europa – l’Ucraina è solo un pretesto – e con lo sbarramento che, caso unico al mondo, l’Europa ha messo alle scorrerie digitali e fiscali compiute dai giganti della Silicon Valley folgorati sulla via di Mar-a-Lago, residenza trumpianissima. Poi qualcosa legato alla ricerca scientifica, magari trainata dal complesso militare-industriale: cioè chimica e farmaceutica. Poi quasi buio. L’ex potenza mondiale ha in mano l’intelligenza artificiale e tutto quel che passa per le reti digitali: per il resto, cioè per il grosso delle fabbriche manifatturiere tradizionali che assorbivano tanta manodopera tradizionale, non è più il supergigante d’un tempo.
Dietro c’è la crisi choc dell’industria tradizionale Usa
La disperazione riguarda sì l’export manifatturiero ma anche l’industria del trasporto marittimo e quella cantieristica: vale la pena di ricordare che non c’è traccia di americani nelle “magnifiche 12” compagnie più importanti del pianeta (eppure i container sono una invenzione del tutto statunitense). Peggio ancora fra i cantieri: come detto, fra i primi dieci solo tre non solo cinesi (ma sudcoreani) e gli ordinativi delle principali flotte mondiali sono tutti concentrati in cantieri cinesi. Uno sforzo ingentissimo di rinnovamento delle proprie navi: quasi al 60% della flotta attuale per Cosco, al di sopra del 40% per Cma-Cgm come per Zim, attorno al 25% per Msc e per Apm-Maersk, poco meno per Hapag Lloyd e poco più per l’alleanza giapponese-singaporeana One.
Gli atteggiamenti sprezzanti hanno però avuto una prima conseguenza: Cma-Cgm, la grande compagnia francese ormai numero due al mondo nel trasporto container, ha annunciato che «investirà nei prossimi 4 anni circa 20 miliardi di dollari negli Stati Uniti», come riferito da “Shipping Italy” nei giorni scorsi. Paradossalmente proprio poco dopo aver firmato con i cinesi un maxi-ordine. Poteva apparire come uno schiaffo alla nuova politica Usa da parte del magnate franco-libanese della compagnia marsigliese Rodolphe Saadé, quartier generale nella via che porta il nome di suo padre, fondatore del gruppo: ma la sua visita al presidente Trump ha ribaltato lo scenario e ha messo sul tavolo, come annota l’autorevole sito genovese, la creazione in territorio americano di 10mila posti di lavoro con «l’ampliamento dei terminal container, la costruzione di un hub per il trasporto aereo di merci a Chicago, l’acquisto di cinque nuovi Boeing 777 cargo e la triplicazione del numero di navi battenti bandiera statunitense gestite dalla sussidiaria American President Lines (da 10 a 30 unità)», oltre a uno stock di navi da costruirsi negli Stati Uniti. Ecco, Trump facendo saltare tutte le pedine sulla scacchiera un giorno sì e l’altro pure, forse mira a questo: ha un debito pubblico enorme e vuol farselo “pagare” dal resto di pedine, torri, alfieri, re e regine in cambio della tranquillità della scacchiera…

Una nave della flotta francese Cma Cgm
“Shipping Italy” richiama un recente report di “Xclusiv Shipbrokers” per segnalare che «se la proposta dell’Us Trade Rapresentative andrà avanti, è probabile che creerà notevoli sconvolgimenti nel mercato globale delle spedizioni marittime, in particolare nei segmenti delle petroliere e delle navi portacontainer, portando a tariffe di trasporto più elevate, che potrebbero alimentare l’inflazione e aumentare i costi logistici per le aziende statunitensi». Con una conseguenza boomerang: «Molti armatori potrebbero evitare del tutto i porti statunitensi per aggirare i costi aggiuntivi, portando potenzialmente a uno squilibrio tra domanda e offerta di navi. Ciò potrebbe mettere a dura prova la capacità di spedizione globale e comportare costi più elevati per il commercio statunitense, minando gli obiettivi del governo statunitense di aumentare la produzione nazionale e rafforzare le esportazioni».
Mauro Zucchelli
DALL’ARCHIVIO: La superpotenza a stelle e strisce: un gigante web & tech ma in crisi nella manifattura tradizionale