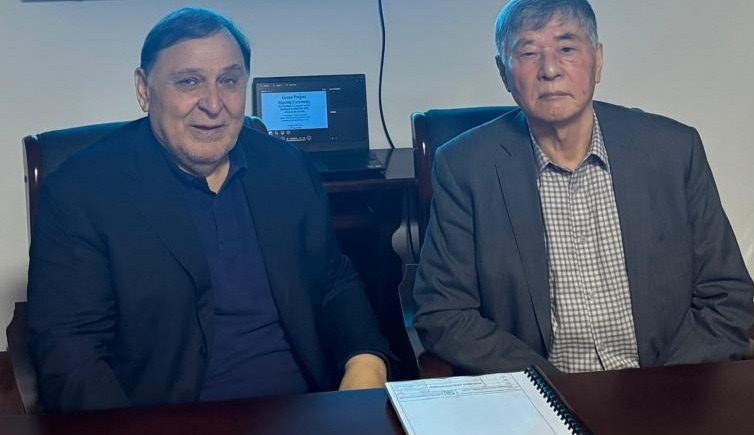Decarbonizzare lo shipping inizia nei porti

Luca Brandimarte
NAPOLI – Non v’è nessun dubbio sul fatto che lo shipping sia anch’esso, al pari di molti altri settori industriali, al centro delle politiche per la decarbonizzazione, di matrice nazionale, ma più sovente europea e internazionale. Non è questa la sede per una approfondita disamina delle varie regolazioni che interessano da vicino l’armamento, ma è bene ribadirle, per quanto in breve: abbiamo l’ETS, Emission Trading System che, per quanto non ancora a pieno regime, è in vigore dallo scorso 1° gennaio; v’è poi la Fuel EU, con il suo regime sanzionatorio in caso di non ottemperanza; e infine il CII (Carbon Intensity Indicator) che prevede un rating per le navi, del tutto simile – per usare un esempio di immediata comprensione – a quello degli elettrodomestici che abbiamo in casa, che in questo caso va dalla A alla E, in cui il primo indicatore rappresenta la migliore prestazione in termini ambientali e l’ultimo la peggiore, situazione in cui l’unità non potrebbe più navigare.
Se insomma la “nave” è al centro delle politiche di sostenibilità – e gli armatori sono quindi chiamati a fare i “compiti a casa”, cosa che sta avvenendo, e più avanti vedremo come – è indiscutibile il fatto che tutti gli attori del comparto siano chiamati a fare la loro parte. Il titolo del panel che ho svolto alla Naples Week per Assarmatori è “Nessun porto è un’isola”; ebbene anche nessuna nave è un’isola, e per arrivare all’obiettivo decarbonizzazione, rispettando questo complesso impianto regolatorio, ha necessità di avere lato terra infrastrutture adeguate e funzionanti. In questo contesto si inserisce il Cold-Ironing, ovvero l’elettrificazione delle banchine che permette alle navi, una volta in sosta in porto, di spegnere i motori e attingere l’energia direttamente da terra. A Barcellona, è notizia recente, nei giorni scorsi per la prima volta anche una nave portacontainer ha potuto usufruire di questo servizio, per la prima volta nel Mediterraneo. Ma anche in Italia ci stiamo muovendo. Come noto, il Fondo Complementare al PNRR ha previsto 700 milioni di euro di investimenti proprio in materia di elettrificazione delle banchine e le varie AdSP, per quanto ci consta, hanno iniziato a muoversi in tal senso ai fini della realizzazione dell’infrastruttura in banchina.
[hidepost]
In questo contesto, non si può che prendere favorevolmente atto della formulazione contenuta nell’articolo 3 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (Cfr. Legge 30 dicembre 2023, n. 214) nella misura in cui il servizio di Cold-Ironing viene definito come un servizio di interesse economico generale in ambito portuale, unitamente alla necessità di garantire per gli utilizzatori finali del servizio (i.e. le navi) condizioni di accesso e di fornitura dello stesso eque e non discriminatorie.
V’è poi il tema di un’auspicata ripresa dei lavori dei tavoli tecnici di concertazione già avviati in sede ministeriale volti alla predisposizione delle linee guida per la definizione sia degli standard tecnici e delle potenze di connessione dei singoli impianti portuali sia delle regole di governance e tariffarie da applicare alla gestione del servizio, oltre che ad un’adeguata definizione dei possibili profili di responsabilità d’interesse per la totalità degli attori coinvolti nel cold-ironing. Su questo tema valgono tre ordini di considerazioni.
In primo luogo, per quanto riguarda la definizione di standard tecnici e potenze, si osserva come da alcune parti sia stata nel corso del tempo sollevata l’obiezione che, in caso di allaccio – si pensi soprattutto alle grandi navi – alla rete elettrica vi sarebbero problemi di fornitura, eventualità che tuttavia – e per quanto ci consta – pare essere stata scartata da chi gestisce la rete e che quindi ben potremmo bollare come fake news.
In secondo luogo, v’è il tema della governance del servizio. Sul punto, non possiamo che auspicare la previsione di un modello gestorio flessibile che – in ogni caso e con riferimento alle aree portuali già assentite in concessione ai sensi dell’articolo 18 delle Legge n. 84/94 – permetta al terminalista di scegliere se gestire in prima persona l’impianto di Cold-Ironing costruito in banchina o meno.
In terzo ed ultimo luogo, v’è il tema della corretta individuazione dei profili di responsabilità che interessano tutti i soggetti coinvolti nella gestione dell’operazione di allaccio-slaccio della nave all’infrastruttura di terra. Occorre nella sostanza regolare in modo puntuale e preciso le relative competenze e conseguentemente i potenziali profili di responsabilità di ogni singolo attore coinvolto. Anzitutto, v’è la responsabilità della messa a disposizione dei fondi da parte dello Stato per la realizzazione dell’infrastruttura.
V’è poi il tema della responsabilità del soggetto gestore del servizio e del fornitore di energia elettrica. Sul punto, infatti, occorrerebbe: (a) individuare il fondamento giuridico della responsabilità; (b) definire i possibili profili di responsabilità che si potrebbero configurare nelle ipotesi di ritardo nella messa in funzione dell’impianto di Cold-Ironing, nonché in caso di mancato / erroneo funzionamento dello stesso. Si pensi ad esempio all’ipotesi di ritardo nell’entrata in funzione dell’impianto, così come quello del mancato e/o erroneo funzionamento dello stesso. Circostanza questa che rileva – al netto ovviamente delle condizioni generali di fornitura dell’energia elettrica applicate ai sensi di legge – anche per quanto attiene ad eventuali profili di responsabilità al soggetto fornitore dell’energia elettrica e che, in ogni caso, potrebbero essere valutati anche sotto il profilo assicurativo a tutela sia della nave sia del terminal.
In sostanza, sarebbe in questo senso necessario prevedere specifiche ipotesi di responsabilità riferite: (i) ad attività od omissioni imputabili alle AdSP (o alle Amministrazioni competenti a livello locale) qualora si verifichino carenze di natura infrastrutturale tali da non permettere ad una determinata nave l’accesso equo ed indiscriminato al servizio (di Cold-Ironing) in banchina; (ii) ad eventuali attività od omissioni imputabili al soggetto concessionario che eroga il servizio (si pensi, a titolo esemplificativo ma non esclusivo, alla mancata manutenzione e/o a malfunzionamenti dell’infrastruttura oppure a carenze organizzative tali da incidere in negativo sull’efficienza del servizio medesimo); (iii) ad eventuali disservizi relativi alla fornitura dell’energia elettrica direttamente imputabili al fornitore della medesima.
Altro punto da menzionare è quello relativo all’interlocuzione del MIT con la Commissione europea con riferimento al progetto di aiuto notificato a Bruxelles per la concessione degli aiuti e la gestione degli impianti di Cold-Ironing ed i relativi oneri di sistema (ivi incluse le responsabilità nei confronti degli utenti). Pratica questa che si è positivamente conclusa con la decisione di compatibilità della Commissione europea dello scorso 17 giugno a mezzo della quale la Commissione ha dato il proprio benestare ad una misura che si sostanzia nella riduzione degli oneri generali di sistema con una dotazione di 570 milioni di euro a valere fino al 31 dicembre 2033.
Da ultimo, in un’ottica di visione d’insieme di tutta la normativa energetica in materia di Fit for 55, si ricorda la necessità che le istituzioni centrali destinino correttamente i fondi messi a disposizione dal regime ETS e dal Regolamento Fuel EU che oggi per legge (anche) destinati anche al rinnovo degli impianti portuali quali la realizzazione dell’infrastruttura OPS e non solo. In questo contesto, per ciò che riguarda l’utilizzo dell’energia elettrica per le navi in porto, l’obiettivo è quello di arrivare ad una futura de-fiscalizzazione della fornitura dell’energia elettrica per rendere maggiormente competitivo il suo utilizzo; iniziativa questa recentemente condivisa anche da ESPO e che dovrà essere saggiamente gestita poiché i fondi per consentire tale de-fiscalizzazione saranno quelli derivanti dai prelievi del regime ETS e Fuel EU a carico degli armatori (fondi che dovranno essere opportunamente intercettati).
Concludiamo con un dato: lo scorso anno dicevamo che il 50% delle navi da crociera era pronta per attingere energia da terra, ma solo il 2% dei porti poteva garantire una adeguata infrastruttura. In un anno, quest’ultimo dato è salito solo di un solo punto percentuale, al 3%, mentre entro il 2035 tutte le unità in navigazione “avranno la spina”. Nessun porto è un’isola, ma anche nessuna nave: l’obiettivo decarbonizzazione può essere alla portata solo se si corre insieme.
Luca Brandimarte
[/hidepost]