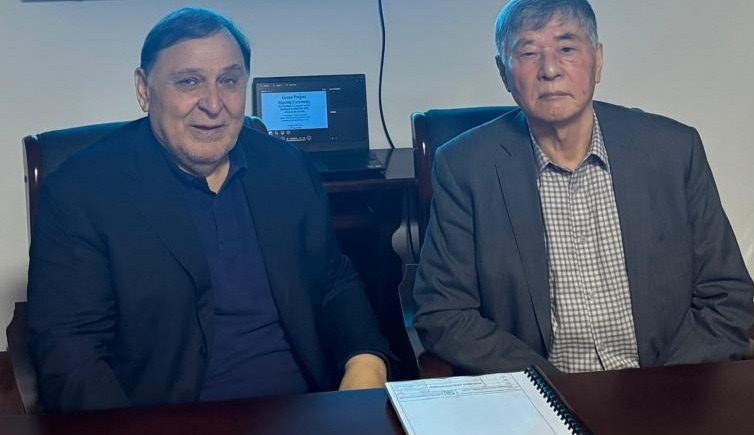Trasporto fluviale e merci

Luca Brandimarte
MANTOVA – Il trasporto fluviale in Italia, sia per le merci sia per i passeggeri, non è talvolta particolarmente preso in considerazione. Ne abbiamo parlato di recente nel convegno nazionale sulla navigazione interna a bordo della motonave “River Queen”. O meglio questo tipo di trasporto non è considerato come ci si aspetterebbe e si vorrebbe. Basti pensare che, con riferimento alla prima categoria, quella merceologica, solo 0,1% transita per una idrovia, contro una media europea che come sappiamo è del 5,6%. Certo, si tratta di un paragone azzardato e che non restituisce una fotografia nitida dello stato dell’arte, visto che la geografia in qualche modo penalizza il nostro Paese rispetto agli altri dell’Unione europea, che possono contare su un numero maggiore di vie d’acqua interne. Detto questo, i margini di miglioramento esistono, sono concreti e in qualche modo questa strada si sta già percorrendo, come il convegno di oggi ampiamente dimostra.
Tuttavia, l’occasione ci offre alcuni utili spunti di dibattito. E per farlo può essere opportuno partire da alcuni dati che riguardano le Autostrade del Mare, ovvero quel sistema di trasporto per cui un rotabile che trasporta merci, anziché percorrere la normale rete terrestre, viene imbarcato su un traghetto Ro-Ro, accompagnato o non accompagnato.
La prima Autostrada del Mare è nata proprio in Italia, negli anni ’70, ed è la Genova-Palermo (ancora prima che si chiamassero così). Da allora sono stati fatti passi avanti significativi, basti pensare che ad oggi l’Italia è leader per quota di mercato nel Mediterraneo (il 40%, la Spagna segue al 19%) e fra i primi cinque armatori al mondo, ben tre sono italiani. Uno sviluppo vertiginoso che ha contribuito a togliere dalla strada centinaia di migliaia di camion, riducendo il traffico, l’incidentalità e l’inquinamento, e realizzando così una vera sostenibilità ambientale. Ma questo sviluppo è stato reso possibile anche grazie ad un contributo pubblico per chi ha scelto questo tipo di intermodalità, un contributo che nel corso degli anni è mutato diverse volte, per nome, consistenza economica e modalità, ma che è stato un asset portante di questo segmento, e infatti come tale è sempre stato giudicato positivamente dalla Commissione europea nelle sue verifiche sugli aiuti di Stato.
[hidepost]
La mia provocazione, se così vogliamo definirla, è proprio questa: perché non spendersi per far sì che possa esistere qualcosa di analogo (chiaramente fatte le dovute proporzioni) anche per il trasporto fluviale di merci?
Ne abbiamo parlato a Mantova, città straordinaria, all’interno però di quella Pianura Padana che tutti noi sappiamo essere, talvolta fortemente, congestionata a causa del traffico veicolare. Ogni scelta che possa ridurre questa situazione deve essere investigata e su tali corde potrebbero esserci presupposti, pro futuro, per arrivare ad un incentivo anche per questa tipologia di trasporto. Questo anche a seguito di un’apposita attività di dragaggio dei fondali fluviali una volta risolte le criticità normative e burocratiche che, talvolta, ancora oggi rendono incerto il panorama.
Sul trasporto passeggeri, da ultimo, e quindi da un punto di vista turistico, è chiaro che un’integrazione degli attuali circuiti turistici esistenti con il trasporto fluviale potrebbe essere un utile spunto al fine di favorire la sostenibilità dello “slow tourism” e portare, allo stesso tempo, anche benefici in termini ambientali.
Luca Brandimarte
[/hidepost]