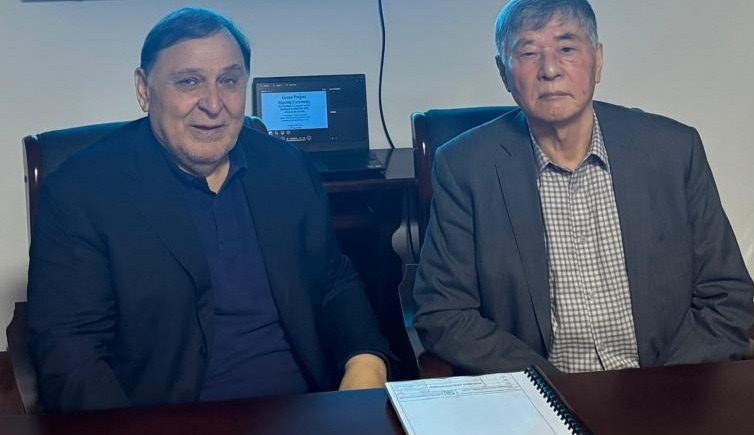L’UE tratta l’estensione dell’ETD

Luca Brandimarte
ROMA – Affrontare il tema della logistica dell’energia è argomento quanto mai di attualità, in particolare per quanto riguarda sia il trasporto marittimo sia per il porto che per il suo indotto nell’ambito di cui – come noto – si misura l’efficienza trasportistica dell’intero Sistema Paese.
In primo luogo si consideri che l’armamento, in particolare dal conflitto russo-ucraino in poi, si sta imponendo sempre di più come un vero e proprio “vettore energetico”, contribuendo con ciò alla sicurezza e all’indipendenza (energetica) del Paese; e in secondo luogo, che lo stesso armamento sia parimenti alle prese con diverse ‘sfide’ che, nell’ottica del tanto atteso processo di de-carbonizzazione, hanno a che fare proprio con la logistica dell’energia.
Con riferimento al primo argomento è sotto gli occhi di tutti la crescente rilevanza assunta dall’armamento negli ultimi anni per sopperire alle problematiche causate dalle crescenti tensioni geopolitiche. Si pensi, per fare un esempio di cui molto si è dibattuto e si continua a dibattere, alle navi-rigassificatore ed ai sistemi di ri-gassificazione che, più in generale, sono oggi un argomento centrale delle strategie portuali di alcune realtà nazionali che, peraltro, incidono altresì su tutte le attività dei porti interessati, dall’armamento, ai terminal fino ai servizi portuali ed ai servizi tecnico-nautici che operano presso tali sorgitori. Parliamo di un’infrastruttura flessibile e non è un caso, infatti, che nei primi due mesi dell’anno il contributo del gas naturale liquefatto arrivato nei quattro terminali italiani da diversi Paesi stranieri, Stati Uniti in primis, abbia pesato di più del gas algerino arrivato “via tubo” a Mazara del Vallo.
[hidepost]
*
In questo senso, si pensi che il GNL ha rappresentato – se prendiamo a consuntivo i mesi di gennaio e febbraio di quest’anno – la prima fonte di approvvigionamento dell’Italia, attestandosi al 20% dei flussi (pari a circa 2,9 miliardi di metri cubi) e superato i volumi in arrivo dall’Algeria “via tubo” (pari a circa il 19% e cioè 2,8 miliardi di metri cubi). I quattro terminali italiani (Rovigo, Livorno, Panigaglia e Piombino) hanno ricevuto GNL principalmente da Usa, Algeria e Qatar, Egitto, Nigeria e Mozambico.
I dati forniti raccontano la crescita dell’approvvigionamento via nave rispetto a quella via tubo e la prossima attesa partenza del rigassificatore di Ravenna parrebbe essere un’ulteriore conferma di quanto sopra. Italia, Germania e Olanda sono gli unici Paesi europei che nei primi due mesi di quest’anno hanno registrato arrivi in aumento rispetto alle media europea, che evidenzia una flessione del 7% a 25 miliardi di metri cubi. Alla luce di ciò, se è vero che il consumo di gas in Europa è sceso al livello più basso degli ultimi dieci anni, per contro, i numeri mostrano che l’approvvigionamento via nave aumenta e questo trend spinge diversi Paesi a costruire nuove infrastrutture. Si pensi, infatti, che dal 2022 a oggi in Europa sono entrati in funzione otto terminali nuovi e altri 13 potrebbero diventare operativi entro il 2030.
D’altro canto, come detto, nel percorso di de-carbonizzazione l’energia e la sua logistica rappresentano un fattore chiave anche per l’armamento in sé e per sé. Proprio nei giorni scorsi a Bruxelles si è tenuta una riunione d’alto livello (“high level working party”) dei rappresentanti dei Ministeri delle Finanze dell’Unione in cui si è discusso se proseguire speditamente nell’estensione dell’ETD (“Energy Taxation Directive”) oppure fermarne momentaneamente la discussione. Aggiungo, in tema di ETD, che nella suddetta riunione dell’High Level Working Party dei rappresentanti dei ministeri delle finanze, l’Italia ha confermato la propria posizione negativa rispetto alla proposta belga di rivedere la direttiva nel senso di escludere la non applicazione di accise per i carburanti navali (assieme ad altri 3-4 paesi). Adesso occorrerà capire se i Belgi posticiperanno il dossier al prossimo semestre (che sarà a guida ungherese e di conseguenza potrebbe mettere da parte molto verosimilmente ETD) oppure proseguire ancora con le negoziazioni.
*
L’Energy Taxation Directive prevede l’estensione della tassazione sui carburanti anche a quelli per uso marittimo, con alcune deroghe per i collegamenti tra e con le isole di uno stesso Stato inserite nella proposta di compromesso della Presidenza Belga rispetto alla prima versione della Commissione. Come già abbiamo visto per l’ETS, analogo rischio di de-localizzazione dei traffici si ha anche per questa misura. Le deroghe infatti non salvaguarderanno da un inevitabile aumento dei costi dei servizi come quelli delle Autostrade del Mare, del feederaggio dei container dai porti di transhipment comunitari, delle crociere di prossimità e ancora, in un ambito strettamente connesso con il trasporto marittimo, non tutelerebbero le entrate dei servizi portuali (meno traffici significa meno tasse portuali e di ancoraggio) e quelle dei servizi di bunkeraggio, andando quindi nostro malgrado ad incidere negativamente anche sulla produzione nazionale di carburante.
Ancora, con riferimento all’AFIR, ovvero il regolamento sulle infrastrutture per i combustibili alternativi, elemento fondamentale per lo shipping per essere “compliant” con le normative nazionali, comunitarie ed internazionali, va sottolineato come il nostro Paese sia il candidato ideale a diventare l’hub energetico meridionale dell’Europa. In questo senso, dunque, sul presupposto che attraverso il Mediterraneo transita circa il 30% del traffico mondiale “Oil & Gas” (di cui il 22% transita per il canale di Sicilia) è ancor più importante far sì che il nostro Paese sia messo nelle condizioni di poter giocare un ruolo cardine, pro-futuro, nella produzione di energie rinnovabili e di carburanti alternativi (quali ad esempio i c.d. “bio-fuels”) da impiegare soprattutto in ambito navale. Va da sé che nel contempo andrà garantito un accesso equo all’infrastruttura portuale da parte del cliente-nave.
*
In conclusione, due brevi riflessioni.
La prima è che, anche alla luce di tutto quanto esposto sopra, l’armamento non può essere lasciato solo nel percorso verso la de-carbonizzazione. Stimiamo che l’armatore più illuminato possa coprire, con i suoi sforzi, una percentuale vicina al 30% di quanto necessario: per il resto, deve essere aiutato e accompagnato dall’industria di terra, sia per quanto riguarda la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione dei fuel alternativi sia per quanto riguarda un’adeguata elettrificazione delle banchine (c.d. “Cold-Ironing”).
La seconda riguarda la geografia politica. Occorre avere ben chiaro a mente come ormai le decisioni più impattanti per tutti i settori, incluso il nostro, vengano prese più a Bruxelles che a Roma. Serve quindi prestare maggiore attenzione al processo legislativo comunitario, onde evitare di essere costretti a intervenire in extremis o, ancora peggio, vedersi calare dall’alto decisioni talmente impattanti per il nostro settore tali da metterne a rischio la sua intera competitività qualora non adeguatamente (e nei tempi giusti) governate.
Luca Brandimarte
[/hidepost]