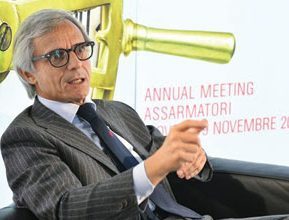L’amm. Angrisano al Senato no a nuove incerte competenze
In discussione il testo della nuova legge sulla tutela del mare – Il consuntivo della tutela delle coste e delle aree protette.

Felicio Angrisano
ROMA – Le Capitanerie di porto sono e devono rimanere il braccio operativo dell’ambiente per la tutela delle aree marine protette. E’ questa la sintesi dell’audizione del comandante generale del corpo ammiraglio Felicio Angrisano alla XIII commissione permanente del Senato sul disegno di legge per la riforma della 394/91 sull’ambiente marino. Pubblichiamo qui di seguito l’abstrac dell’audizione.
Sono grato di poter offrire il punto di vista del comando generale sul progetto di riforma della legge sulle aree protette, occasione che mi consente di testimoniare il ruolo e la funzione che il corpo storicamente svolge a tutela dell’ambiente e dell’ecosistema marino nella sua interezza.
Dopo aver ricordato che già la legge 963 del 1965 aveva conferito al Corpo le funzioni tuttora concernenti: la vigilanza e controllo in materia di tutela dell’ambiente marino e costiero, incentrati sul ruolo di direzione del comandante del porto, il coordinamento e la condotta, a livello “locale”, degli interventi di lotta all’inquinamento inclusa la potestà di dichiarare l’emergenza locale per l’impiego diretto delle risorse strumentali pubbliche e private disponibili; il concorso, quale soggetto tecnico di riferimento, per la gestione dell’emergenza nazionale, nel quadro del piano nazionale antinquinamento; l’emanazione dell’atto di diffida ai comandanti delle unità che si siano rese responsabili di condotte inquinanti.
[hidepost]La stessa legge, inoltre aveva introdotto nell’ordinamento italiano il concetto di “riserva marina”, attribuendo alle Capitanerie di porto la relativa attività di vigilanza.
L’istituzione, ai sensi della legge n. 349/1986, del ministero dell’Ambiente, consolida il ruolo e l’impegno del corpo, ponento le Capitanerie di Porto – Guardia Costiera alle dipendenze funzionali del neo-istituto dicastero.
La struttura territoriale del corpo viene così consacrata quale organizzazione operativa periferica del ministero dell’Ambiente per le zone marittime e costiere.
Ulteriore espressione di tale dipendenza funzionale caratterizza la vigilanza finalizzata a contrastare la riduzione delle risorse ittiche, assicurare il mantenimento e la conservazione della biodiversità e garantire la protezione del territorio, senza però escludere da essa il compatibile sviluppo delle attività antropiche.
In forza di tali mandati dispositivi, il corpo esercita, in via prevalente, nelle zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale, l’attività di controllo sull’esatta applicazione delle norme.
Norme rientranti nel diritto interno, europeo ed internazionale, relativa alla prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, da navi, dalla costa, da immersione di rifiuti, da attività di esplorazione e sfruttamento dei fondali marini, compreso l’inquinamento atmosferico, nonchè del patrimonio storico ed archeologico.
L’azione di tutela ambientale trova nel corpo delle Capitanerie di porto una straordianaria sintesi tra potestà amministrative e funzioni specialistiche di vigilanza.
Essa si completa in quell’unicum di competenze che l’ordinamento – coerentemente – attribuisce all’autorità marittima per il controllo sulle attività di pesca, e del relativo sforzo e per la vigilanza sul corretto uso del demanio marittimo.
La tutela che il corpo assicura nelle aree marine protette inizia “da terra”, con il contrasto all’abusivismo demaniale ed il controllo degli scarichi, ma parte anche “dal mare”, dalla vigilanza sulle attività di pesca, ultimo anello della filiera della tutela ambientale.
Altre finalità dell’azione di controllo sono il contrasto all’utilizzo di attrezzi non consentiti e la protezione delle specie ittiche di cui è vietata la cattura.
Significativo, al riguardo, il risultato dell’attività di contrasto all’utilizzo di reti da posta derivanti (spadare): finora sono state sequestrate oltre 4 mila chilometri di rete (un’estensione superiore alla distanza intercorrente tra Roma ed Helsinki).
Messe a sistema, le citate funzioni e competenze, lasciano chiaramente emergere quale sia il ruolo svolto dalle autorità marittime per la tutela “integrata” dell’ambiente e per la “risorsa” mare.
La rilevanza dell’impegno del corpo per la tutela dell’ambiente marino, ha condotto all’isituzione, ad opera della legge 31 luglio 2002, n. 179, del reparto ambientale marino, unità organizzativa del corpo incardinata proprio all’interno del dicastero ed inquadrata tra gli organismi di supporto tecnico del predetto.
Il progressivo accrescersi degli oneri funzionali attribuiti al corpo ha determinato, di pari passo con competenze professionali specifiche, l’acquisizione di assetti aeronavali dedicati alla vigilanza ambientale ed al monitoraggio delle coste e del mare, via via adeguati alle mutevoli e crescenti esigenze di salvaguardia dell’ambiente.
Tali esigenze di tutela trovano risposta nelle funzioni svolte in materia di sicurezza della navigazione e di monitoraggio con capacità “selettive” del traffico marittimo.
Non deve trascurarsi, infatti, che le autorità marittime sono in grado, grazie al quadro informativo di cui possono disporre attraverso l’utilizzo dei sistemi tecnologici che compongono il VTMIS (sistema di monitoraggio ed informazione del traffico navale), di controllare, anche e soprattutto in funzione preventiva, i molteplici fattori di rischio ambientale derivanti e ricollegabili alla navigazione marittima.
Il relativo quadro conoscitivo dei vettori navali e delle merci pericolose trasportate, consente di articolare, in maniera coerente e coordinata, sia le azioni di controllo che quelle di risposta, non solo in caso di emergenze ma anche per l’esercizio ordinario di poteri di polizia marittima.
Rispetto alle specifiche tematiche oggetto dell’esame di codesto consesso, appare incontrovertibile che, a più di vent’anni dalla sua entrata in vigore, si prenda in considerazione un adeguamento della Legge 394/91 alle mutate esigenze della tutela e valorizzazione dell’ambiente secondo i principi di matrice comunitaria di “precauzione” e “sfruttamento sostenibile”.
A tal riguardo, esprimo il mio avviso favorevole all’iniziativa di riforma, purchè l’innovazione faccia salvi gli elementi strutturali della disciplina della vigilanza e controllo, utili a preservare, concretamente, i valori ambientali, l’ecosistema, gli habitat e le specie che li popolano, nel rispetto delle attribuzioni e delle funzioni consolidate.
Sino ad oggi, l’impianto della legge è riuscito ad assicurare la tenuta dei necessari equilibri interistituzionali ed ha garantito il pieno rispetto dei ruoli oltre alla valorizzazione delle specialità.
Pertanto, non mi trovano d’accordo le eventuali proposte di modifica che tendono a realizzare nuovi ed incerti assetti di competenze che potrebbero minare quell’equilibrio, tra dicastero dell’ambiente, enti locali, consorzi di gestione ed autorità marittime, già ampiamente e positivamente “collaudato”, all’interno del quale il corpo si fa carico di porre in essere una vera e propria “tutela integrata” della risorsa mare.
Tale assetto, peraltro, non ha tradito le aspettative proprie del momento storico nel quale la Legge 394/91 ha visto la luce, permettendo di conseguire importanti risultati per la salvaguardia di ecosistemi tanto delicati, quanto, il più delle volte, estremamente esposti.
Per l’attività di sorveglianza attuata dal corpo nelle 30 aree marine protette ad oggi istituite (228 mila ettari di mare e circa 700 km di coste), faccio riferimento ai soli dati statistici relativi all’ultimo triennio, in cui, su un totale di circa 60 mila missioni svolte dal corpo, per la tutela dell’ambiente marino e costiero, oltre 18 mila sono state dedicate esclusivamente alle aree protette.
Oltre alla vigilanza c.d. “attiva”, dispiegata attraverso gli assetti aero-navali, il corpo, mediante sofisticate strumentazioni tecnologiche, opera un monitoraggio “passivo” di tutte le unità navali dotate di Ais (automatic identification system) che, transitando in prossimità del perimetro delle aree marine protette, ricevono apposita segnalazione – visualizzata graficamente sulla cartografia digitale di bordo – che consente il rispetto dei limiti fissati e la individuazione, anche successiva, delle eventuali violazioni.
Anche nelle 17 “aree di reperimento”, nei 10 siti Aspim (aree specialmente protette di importanza mediterranea), nell’area soggetta a speciale protezione (PSSA) delle bocche di Bonifacio ed all’interno delle aree marine costiere di rilevanza comunitaria, nazionale e/o regionale, lo sforzo complessivo dell’ultimo triennio ha fatto registrare oltre 350.000 ispezioni, controlli e visite in materia di inquinamento; oltre 50 mila interventi per fenomeni di inquinamento; più di 1000 diffide amministrative, notificate ex lege 979/82 ai soggetti individuati come responsabili, accertando circa 300 infrazioni di natura penale e più di 2000 illeciti amministrativi.
In coerenza con i principi e gli equilibri su cui, sin’ora, si è retto il sistema di controllo e tutela delle aree marine protette, quindi, la previsione di nuovi attori istituzionali, l’estensione delle competenze ad altri organi e la conseguente frammentazione delle risorse, anziché la valorizzazione delle specialità, delle professionalità e degli assetti esistenti, darebbe luogo a duplicazione di compiti, generando difetti di coordinamento e dispersione degli sforzi.
Ciò determinerebbe un depotenziamento della funzione di controllo ed una sottovalutazione della descritta esigenza di concepire l’azione di tutela delle aree marine protette e dell’ambiente marino in generale in maniera “integrata” ed “integrale”.
Nell’ambito dell’azione di vigilanza delle aree marine protette, dunque, la generica inclusione dei “reparti di mare” di altre forze ed amministrazioni, preposte allo svolgimento di altre funzioni, pone una grave criticità.
Tanto in considerazione del fatto che il soggetto pubblico deputato alla vigilanza dispone di personale specializzato, di risorse e dotazioni strumentali commisurate al perseguimento delle specifiche finalità di tutela ed adeguate ai relativi contesti, di particolare pregio ambientale.
Diversamente, si determinano, così, oltre ai citati problemi di coordinamento operativo e di dispersione delle risorse che il dicastero di riferimento impiega al riguardo, effetti non in linea con i prevalenti criteri di razionalizzazione delle competenze alla luce di una progressiva riduzione della spesa pubblica ed accorpamento di funzioni omogenee tra organi dello stato.[/hidepost]